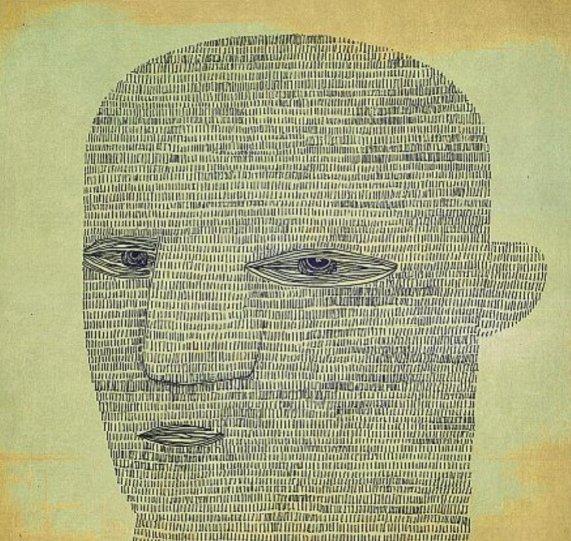da L'Internazionale, di Christoph Gurk, Süddeutsche Zeitung, GermaniaSi pensa che gli abitanti dell’Uruguay vivano bene perché sono pochi. Ma le ragioni sono più profonde: è un paese progressista, laico, rispettoso del bene comune e delle istituzioni.
Non sono tempi facili, lo sa bene anche Raymond De Smedt. Il sogno americano è imploso; la terra promessa è lacerata da una terribile guerra; le democrazie degenerano in dittature; le nazioni ricche di risorse rischiano la bancarotta e in tanti sognano solo di andarsene da qualche altra parte. Ma non De Smedt : lui vuole rimanere in Uruguay, “un paese straordinario”.
È mattina presto a Rocha, nell’est del paese. Fuori dalla finestra le nuvole autunnali incombono sul poggio su cui sorge la tenuta di De Smedt. Si chiama Estancia El Alamo, ha seimila ettari di boschi e prati e una casa padronale costruita nel 1860 con decorazioni in legno scuro e parquet che scricchiola a ogni passo. Nel camino crepita il fuoco e De Smedt ci è seduto accanto. Ha 86 anni, è nato in Belgio e ha vissuto e lavorato praticamente in tutto il mondo: in Sudamerica e a Singapore, in Cina e negli Stati Uniti, in Indonesia e in Russia. Ma una ventina d’anni fa ha scelto l’Uruguay come sua residenza definitiva. “Lo rifarei anche oggi”, dice.
L’Uruguay è stretto tra il Brasile e l’Argentina, due paesi che prendono il nome dalle ricchezze che c’erano un tempo sui loro territori o che le persone speravano di trovarci: il prezioso legno rosso di un albero locale in Brasile e l’argento in Argentina. L’Uruguay si chiama così dal fiume omonimo. Il nome ufficiale del paese è Repubblica orientale dell’Uruguay, più una descrizione geografica che un nome.
Basterebbe questo per capire che nessuno qui si è mai sentito troppo importante. È vero che nel 1930 l’Uruguay ospitò e vinse i primi mondiali di calcio e che per un bel po’ fu considerato “la Svizzera del Sudamerica”. Ma è stato tanto tempo fa. Nel calcio la nazionale non è più una squadra da temere e anche dal punto di vista del benessere e della sicurezza la situazione non è idilliaca come una volta: nel 2024 ci sono stati 10,6 omicidi ogni centomila abitanti, il doppio degli Stati Uniti. E a Montevideo, la capitale, a volte si vedono intere famiglie dormire per strada.
Si potrebbe pensare che Raymond De Smedt si sia ingannato scegliendolo come sua residenza stabile. Ma non è l’unico a fare il tifo per l’Uruguay.
Mentalità diversa
Il paese ha dei problemi innegabili, come l’alto tasso di abbandono scolastico, la criminalità o la scarsa crescita demografica, ma ha anche dei lati sorprendentemente positivi. Il rapporto mondiale sulla felicità colloca l’Uruguay prima della Francia e del Brasile, a cui è subito dietro nelle statistiche per la solidità democratica. Nella lotta alla corruzione è perfino davanti alla Germania.
L’Uruguay ha il pil pro capite più alto del Sudamerica e il tasso di povertà più basso. L’economia cresce, le emissioni di anidride carbonica diminuiscono, e i populisti e gli estremisti di destra hanno un ruolo marginale nella società e nella politica. La sua, secondo il settimanale britannico The Economist è una “storia di successo in America Latina”; per il New York Times è un “miracolo silenzioso della democrazia”. Incuriositi, abbiamo voluto vedere cosa rende il paese migliore degli altri. Magari il resto del mondo ha qualcosa da imparare.
Quando si parla del successo dell’Uruguay, spesso si chiamano in causa le sue dimensioni e la scarsa densità demografica. In una superficie che è il doppio dell’Austria (poco più di 176mila chilometri quadrati) vivono meno persone che a Berlino: 3,5 milioni secondo l’ultimo censimento, a cui si aggiungono circa dodici milioni di bovini. Di questi, cinquemila appartengono a De Smedt. “Vieni, te li faccio vedere”, dice mettendosi il cappello e prendendo posto nel sedile posteriore dell’auto. Al volante c’è un suo dipendente. Il pick-up sobbalza lungo strade sterrate, tra fango e buche. Alcuni uccelli si alzano in volo, un nandù solleva curioso il lungo collo.
Il fatto che oggi allevi bovini, dice De Smedt, è una specie di ritorno alle origini. Un tempo, in Belgio, anche i suoi genitori avevano mucche e vitelli e vendevano la carne nella macelleria di famiglia. Da bambino doveva aiutarli, ma finì comunque le scuole, studiò geologia e poi prese una laurea in ingegneria.
Negli anni sessanta entrò nel settore petrolifero e agli inizi degli anni settanta il suo lavoro lo portò per la prima volta in Sudamerica, in Argentina. Ma anche in Uruguay. Si innamorò subito del paese, non perché aveva molto da offrire, ma per la ragione opposta: “Qui non c’è praticamente niente”, dice De Smedt. L’Uruguay ha poche ricchezze naturali e il suolo, rispetto a quello delle nazioni confinanti, è decisamente più povero. E Montevideo non ha un’offerta culturale paragonabile a quella di città come Buenos Aires, São Paulo o Rio de Janeiro. “Sono le persone a rendere il paese speciale”.
L’auto sobbalza sempre più forte, De Smedt deve aggrapparsi alla maniglia di sostegno. L’opinione per cui in Uruguay si sta bene perché è piccolo e poco popolato gli sembra una semplificazione. Anche altri paesi sono così. La sua unicità sta nella mentalità, afferma.
Fare le cose a la uruguaya significa non correre, guardare ai risultati sul lungo periodo invece che ai guadagni immediati.Basta pensare agli allevamenti: per un breve periodo all’inizio del novecento resero l’Uruguay uno dei paesi più ricchi del mondo e ancora oggi sono un settore abbastanza redditizio. Potrebbero far guadagnare di più, per esempio usando gli ormoni o gli antibiotici. Entrambe le cose però in Uruguay sono vietate già da quarant’anni. La maggior parte dei bovini bruca l’erba dei prati per tutta la vita senza toccare i mangimi confezionati e vive all’aperto, non nelle stalle. Non è il massimo se si punta a ingrassare rapidamente gli animali e a fare profitti, ma è molto meglio per il loro benessere e per la qualità della carne.
Con la sua fattoria De Smedt vuole fare un passo ulteriore. Scende dall’auto e si avvicina a un recinto. Dall’altra parte, due gauchos spingono una mandria di mucche con i loro vitelli verso un nuovo pascolo. Gli animali sono robusti e hanno una folta pelliccia scura.
Spostandosi di pascolo in pascolo, dice De Smedt, l’erba ricresce nel modo migliore e assorbe la quantità massima di anidride carbonica. Si chiama allevamento a impatto zero e anche se per ora non è redditizio con il tempo lo diventerà: non richiede l’uso di fertilizzanti e pesticidi, dato che la rotazione migliora la qualità dei terreni. “In sostanza guardiamo crescere l’erba”, dice con piglio decisamente uruguaiano, anche se con un leggero accento straniero.
Viaggiando verso sud dalla sua fattoria incontriamo piccoli villaggi, case unifamiliari e strade costeggiate da alberi. Le persone si sistemano sul marciapiede con le sedie da campeggio, chiacchierano e bevono il mate.
Ormai anche gli uruguaiani fanno battute sulla loro presunta calma. Il paese sarebbe il miglior rifugio al mondo in caso di catastrofe, dicono: perfino l’apocalisse arriverebbe con una ventina d’anni di ritardo. Naturalmente anche lo scienziato Néstor Da Costa conosce queste battute. Le trova divertenti, ammette nella sua casa di Montevideo, ma dicono solo una mezza verità.
Nel 2013 l’Uruguay è stato il primo paese al mondo a liberalizzare il consumo di cannabis. E un anno prima era stato il secondo paese del Sudamerica a depenalizzare l’aborto.
Una questione privata
La lista è lunga. Nel 1913 l’Uruguay introdusse il divorzio per volontà della donna e nel 1877 l’obbligo scolastico generale, quarant’anni prima della Germania. “In molti ambiti l’Uruguay è progressista”, dice Da Costa. Questo a sua volta ha a che vedere con un’altra peculiarità: la netta divisione tra stato e chiesa. Ufficialmente nel paese il Natale e la Pasqua non si celebrano: sono stati trasformati in “giornata della famiglia” e “settimana del turismo”.
“Forse siamo lo stato più laico del mondo”, afferma.
È venerdì pomeriggio e Da Costa è rientrato a casa dall’università. Ha 64 anni, porta un gilet e gli occhiali, ed è uno dei sociologi della religione più importanti del paese. Ma “non siamo poi molti”, dice.
Già bambino Da Costa si accorse che il suo paese era diverso dagli altri. Una volta una zia lo portò in viaggio in Argentina, dove la costituzione obbliga il governo a promuovere la fede cattolica. All’epoca, racconta, per le strade di Buenos Aires “le persone si facevano il segno della croce solo perché passavano davanti a una chiesa”. Le edicole esibivano riviste religiose.
“È impensabile in Uruguay”, dice. Con più di mezzo miliardo di fedeli, di cui più di cento milioni solo in Brasile, il Sudamerica è considerato il continente cattolico per antonomasia. Ma non si hanno dati ufficiali sul numero di persone battezzate in Uruguay o su quello dei cattolici praticanti. “La fede è una questione privata”, dice Da Costa. Per questo da più di cent’anni i censimenti non fanno domande sull’appartenenza religiosa.
Ci sono delle spiegazioni storiche: la chiesa cattolica non si è mai davvero interessata all’Uruguay per via del numero ristretto di abitanti e delle scarse ricchezze naturali. Il clero a malapena reagì quando, all’inizio dell’ottocento, i figli delle famiglie più ricche tornarono dai loro viaggi in Francia importando le idee della rivoluzione: libertà, uguaglianza e fraternità, ma anche la ribellione verso la fede e la religione. All’inizio, racconta Da Costa, ci si limitava a prendersi gioco dei cattolici, per esempio con grigliate pubbliche durante il digiuno del venerdì santo organizzate “davanti alle chiese cattoliche”. Ma presto arrivarono le prime leggi e i divieti: nel 1859 i gesuiti furono espulsi dal paese e due anni dopo i cimiteri furono statalizzati. Dal 1917 la separazione tra stato e chiesa è stabilita dalla costituzione. Da allora una ventina di villaggi e città hanno cambiato il loro nome perché era legato al culto dei santi. Per esempio Santa Isabel, una località nel centro del paese, è diventata Paso de los Toros.
Le croci furono bandite dalle aule e l’ora di religione fu cancellata. Al suo posto, continua Da Costa, i bambini furono educati a venerare gli eroi nazionali, come José Artigas, un generale e politico considerato il padre dell’indipendenza. Anche Da Costa a scuola doveva cantare una canzone in suo onore. Si ricorda ancora il testo: “Padre nostro Artigas, signore della nostra terra”. Non è un caso che suoni come una preghiera: lo scopo era creare una religione civile, una religione dei cittadini che non contemplasse la fede in Dio ma nello stato e nelle sue istituzioni.
Se altrove è stata la chiesa cattolica a occuparsi delle persone, in Uruguay ci ha pensato lo stato, garantendo l’istruzione, e costruendo ospedali e cimiteri pubblici.
Ha funzionato? Le persone hanno davvero più fiducia nello stato? “Senza dubbio”, dice Da Costa. Negli anni novanta un’ondata di privatizzazioni caratterizzò le politiche di tutta l’America Latina e molte aziende statali furono vendute. Anche il governo di Montevideo pensava di fare qualcosa di simile, ma un referendum popolare si pronunciò contro quei piani: i cittadini preferivano lo stato ai privati.
La fiducia nelle istituzioni è grande, prosegue Da Costa, e anche nei politici.
Il più rispettato è stato José Pepe Mujica, guerrigliero negli anni settanta, presidente dal 2010 al 2015, morto lo scorso maggio. Mujica donava gran parte del suo stipendio da presidente e invece di una limousine guidava un vecchio e malconcio maggiolino Volkswagen. A volte dava un passaggio agli autostoppisti.
Durante la dittatura militare in Uruguay, dal 1973 al 1985, Mujica rimase in prigione per più di un decennio, per alcuni anni in isolamento, con le formiche come unica compagnia. Eppure, quando fu eletto presidente non volle che i criminali della giunta militare fossero processati. Le associazioni per la difesa dei diritti umani lo criticarono, ma per Mujica la giustizia aveva anche “la puzza della vendetta”. Secondo lui, era più importante riuscire ad avvicinare gli avversari.
“Questo desiderio di consenso è molto tipico”, dice Da Costa.
Consenso ampio
Ramón Méndez Galain va oltre: per lui il desiderio di unità è uno dei segreti del successo del paese.
Méndez ci riceve sulla porta, ha una barba grigia e indossa una vecchia maglietta. Stava lavorando in giardino, dice. Ci invita a entrare in un ambiente piccolo, che fa da soggiorno e da ufficio. Alla parete è appeso un arazzo con motivi indigeni e sulla scrivania ci sono volumi illustrati sulle piante e la storia dell’Uruguay.
Méndez si lascia cadere sul divano. È un fisico di 64 anni che ha passato la prima parte della sua vita professionale a fare ricerche sul big bang e sulle origini dell’universo. Oggi è più interessato al presente e al futuro che al passato: è una sorta di pioniere della transizione energetica dell’Uruguay.
In appena quindici anni il paese si è convertito quasi integralmente alle fonti rinnovabili di energia, idrica, eolica, solare e biomasse. “Nel 2024 siamo arrivati al 99,1 per cento”, dice.
Anche altri paesi hanno un bilancio energetico simile, per esempio la Norvegia o il Nepal. Ma possono contare su enormi montagne e fiumi impetuosi da sbarrare. In Uruguay la vetta più alta raggiunge i 513 metri. E anche se alcune dighe hanno fornito a lungo energia, all’inizio degli anni duemila non bastavano più.
L’economia era in piena espansione, il tasso di povertà stava calando e per soddisfare il fabbisogno energetico l’Uruguay doveva importare grandi quantità di petrolio e gas per le centrali elettriche. Tutto questo aveva un costo, così il governo si mise alla ricerca di soluzioni e finì per scegliere l’energia nucleare. “All’epoca mi chiesi se fosse davvero la strada migliore”, racconta Méndez. Cominciò a studiare i rapporti e a parlare con esperti, a fare i suoi calcoli. “Volevo fare la mia parte per il paese in quanto fisico”, dice.
Presto arrivò alla conclusione che l’opzione migliore non era il nucleare, ma le energie rinnovabili. I motivi? Costi minori, niente emissioni, più posti di lavoro e più indipendenza. Scrisse anche una sorta di piano d’azione per una possibile transizione energetica del paese e il documento finì sul tavolo del presidente.
“Siamo un paese piccolo”, dice Méndez alzando le spalle. Nel 2008 diventò ministro dell’energia e mantenne la carica anche quando nel 2009 José Pepe Mujica vinse le elezioni. Il nuovo presidente gli pose una condizione: prima di mettere in pratica la transizione energetica voleva raggiungere un consenso ampio che superasse le divisioni tra i partiti. Nacque così una commissione composta sia da persone del governo sia da politici dell’opposizione. “Abbiamo confrontato i numeri e cercato la soluzione migliore per l’Uruguay”, spiega Méndez. Alla fine tutti si sono trovati d’accordo sulle energie rinnovabili.
In un angolo della stanza, davanti a uno scaffale, ci sono dei modelli di pale eoliche. Le stesse che, dice Méndez, sono state costruite in gran numero in tutto il paese, insieme agli impianti solari. Da parte della popolazione non c’è stata praticamente nessuna resistenza. Al contrario, “tutti erano d’accordo fin dall’inizio che fosse la cosa migliore per il paese”, dice il fisico.
Così in Uruguay sono arrivati 4,3 miliardi di euro di investimenti in progetti di transizione energetica e sono stati creati cinquantamila posti di lavoro. È ovvio che questi risultati non possono essere semplicemente riprodotti copiando le misure adottate in Uruguay, ma il paese sudamericano ha comunque una lezione da dare al mondo: “Senza consenso non si può fare nulla”. È quello che Méndez ripete sempre quando partecipa a conferenze e riunioni in giro per il mondo.
Sensibilità ecologista, democrazia stabile e vita rilassata: lo stile dell’Uruguay comincia lentamente a farsi notare.
Una donna britannica che da anni lavora a Montevideo come consulente per l’immigrazione afferma che le richieste di accesso nel paese si sono quadruplicate, soprattutto dagli Stati Uniti. Anche le agenzie di traslochi parlano di dati simili. “È l’effetto Donald Trump”, dice.
E poi c’è il fatto che l’Uruguay rende la vita facile agli immigrati: per ottenere un permesso di soggiorno stabile basta dimostrare di avere un reddito, un certificato di buona condotta, una residenza e alcune vaccinazioni. “Tutto qui”.
La donna ha solo un consiglio da dare a chi decide di stabilirsi in Uruguay: “Fate le cose con calma”.
Si trovano bene soprattutto le persone che cercano una vita tranquilla.
Raymond De Smedt non ha più bisogno di sentirselo dire. Il fuoco nel caminetto della sua fattoria è ormai spento, ma fuori, in terrazza, le braci del barbecue ardono ancora. Sul tavolo c’è un grande piatto di carne del suo allevamento.
De Smedt si è ritirato dalla gestione dell’azienda. Oggi sono le figlie a dirigere l’Estancia, ma da remoto: una vive in Paraguay e l’altra nei Paesi Bassi. De Smedt, invece, non riesce più a immaginare di vivere lontano dall’Uruguay. Poi ci saluta, è da poco passata l’una: è l’ora della siesta.